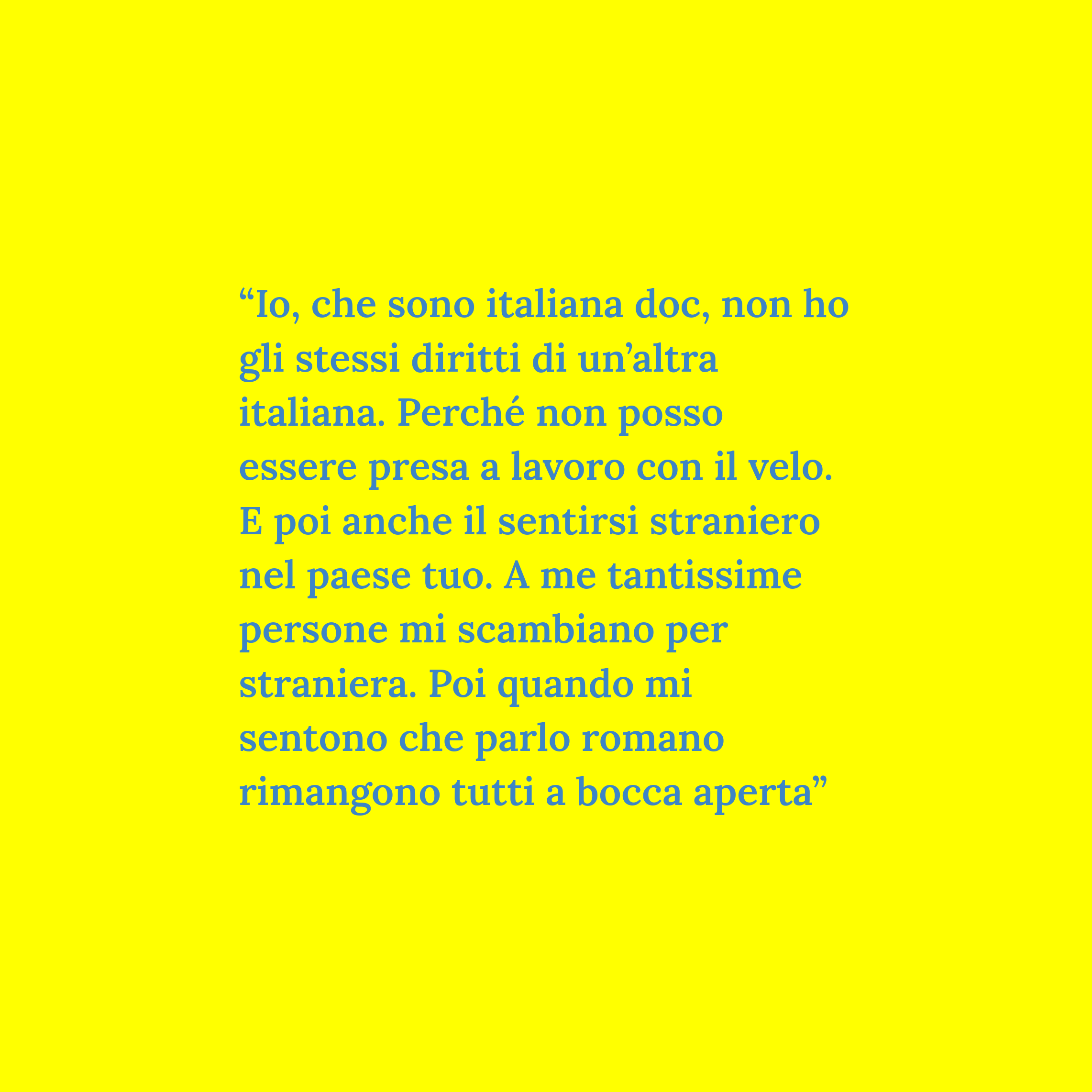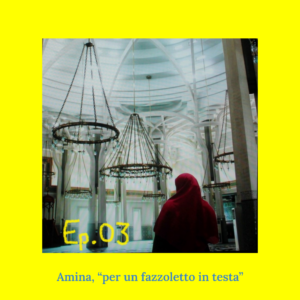[15 giugno 2022]
In una calda e asfissiante sera di giugno il contatto visivo – appuntamento abituale e al buio – tra me e quella cintura grigia che è il GRA veniva tagliato per qualche secondo dal camioncino dei rifiuti, che proprio quella sera si presentava di fresca verniciatura. Sulla fiancata destra dell’automezzo brillava “Ama, per un futuro sostenibile”.
Ora quel bisillabo, oltre essere l’acronimo di “Azienda Municipale Ambiente”, costituisce una più che precisa strategia comunicativa bivalente: l’una già specificata, l’altra finalizzata a evocare il verbo amare. Cioè il verbo esortativo/imperativo (ama, tu!), seguito poi da un complemento di fine “per un futuro sostenibile!!”.
Terminata l’analisi logico-grammaticale e calata la notte, l’indomani mattina – sempre di quel giugno caldo e asfissiante – i cittadini malagrottesi si svegliarono con la notizia sull’incendio del TMB: le fiamme divampavano iraconde, bruciando lo schermo del televisore. E mentre la nube tossica s’impadroniva del quartiere spodestando lo smog, il cielo si fece sempre più nero. Ma non capimmo che fu anche perché era in lutto. Nel Bellunese, in un’anonima mattina del 15 giugno, i pompieri domarono le fiamme di un camper che stava andando a fuoco, sedando quindi le grida strazianti di Cloe Bianco.
Come i rifiuti ci differenziano: profughi, immigrati, stranieri, persone con disabilità, lgtbq+, poveri nei TMB, nei CPR, nelle case andate a scatafascio, nelle carrozzine dentro le mura domestiche, nei camper o nei box. E poi ci isolano con un materiale altamente infiammabile – tristezza, depressione, solitudine e via discorrendo – finché poi accendono la miccia.
È qui che muore la democrazia. È qui che viene parcellizzata, smistata, differenziata e resa mero successo comunicativo. Non fu infatti casuale la visita del giorno dopo di un sindaco che avrebbe fatto il sopralluogo, concludendo infine così “le fiamme dell’incendio a Malagrotta sono sotto controllo e il danno per la salute dei cittadini scongiurato”.
[6 mesi dopo]
Mercoledì, 14 dicembre, è stata archiviata l’inchiesta avviata dopo la morte della Docente Cloe Bianco: nessun reato di istigazione al suicidio per la procura di Belluno.
Leggere le righe degli articoli in circolazione significa anche avvertire la sussistenza e la fondatezza di una verità silenziata, l’ennesima. Cloe Bianco non ha praticato autochiria perché annoiata dalla vita, anzi. Un’entità che non ci è estranea – e che Cloe Bianco chiama “società” nel suo blog – ha esercitato violenza, accendendo in lei dolore atroce e poi infiammato. Demansionata – umiliata – derisa – relegata in segreteria, Cloe Bianco oggi può ancora insegnare. Insegnarci a vivere insieme. A convivere. Nel suo blog PERsone TRANSgenere è possibile imparare cosa significa essere minoranza, essere bruttƏ in una maggioranza che tende e ostenta il bello. Cloe Bianco ci insegna le parole. Non disperdiamole.